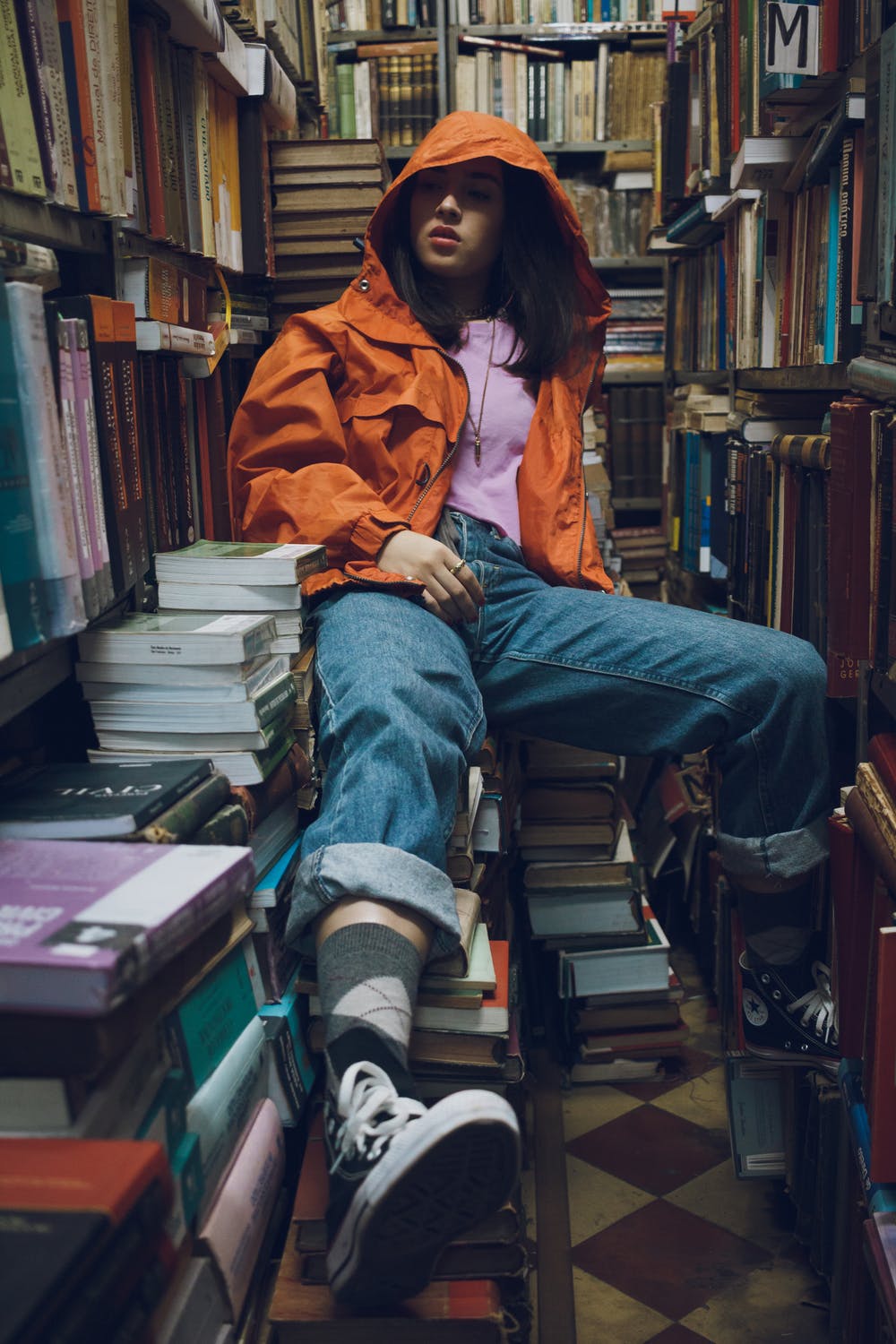A qualche settimana dall’arrivo del coronavirus in Italia, placato in pochi giorni il panico che ha svuotato scaffali dei supermercati, ristoranti e strade delle città, l’ondata della paura ha cominciato ad alternarsi sempre più a insofferenza per i divieti imposti e al crescente desiderio di ritorno alla normalità. Le immagini delle code alle stazioni sciistiche del Nord Italia e dei tavolini affollati sui Navigli milanesi hanno fatto in breve il giro del web, costringendo il governo a misure ancora più dure. Che non è detto siano esaurite.
A calmare gli animi e incoraggiare i cittadini a non chiudersi in casa aveva però contribuito il mondo dell’informazione che, inizialmente accusato di fare allarmismo, ha iniziato a spostare l’attenzione dal bollettino dei contagi in rapido aumento al numero di persone guarite, sottolineando sempre l’età avanzata delle persone decedute. Così, mentre intorno a noi crescevano i timori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il resto del mondo ci chiudeva le porte, il nuovo vento della rassicurazione ha iniziato a soffiare sull’Italia: “Basta con la psicosi!”, “Se ne parla troppo, è come un’influenza”, “Possiamo stare tranquilli: alla fine muoiono solo i vecchi”.
Ma chi sono poi questi vecchi? Secondo il più grande studio epidemiologico condotto sinora sul Covid-19 dal Chinese Centre for Disease Control and Prevention su oltre 70mila pazienti, il più alto tasso di mortalità si ha sopra gli 80 anni (14,8%), ma inizia a crescere, rispetto a quello della popolazione generale, già dopo i 60 anni, un’età che da tempo non associamo più al termine “anzianità”.
Si parla anche di persone affette da gravi patologie preesistenti, contribuendo a tratteggiare nell’immaginario collettivo il ritratto di persone già da tempo ormai irrimediabilmente compromesse nella propria autonomia. Dallo studio cinese si osserva invece come la maggior parte delle persone che ha perso la vita per il Covid-19 fosse affetta da patologie croniche molto diffuse con l’avanzare dell’età, come le malattie cardiovascolari, il diabete e l’ipertensione, condizioni che rendono sì le persone più fragili e vulnerabili, ma non di per sé moribonde.
Il sollievo con cui l’opinione pubblica ha accolto le notizie sull’età della maggior parte delle persone decedute, in realtà, non fa che rivelare la considerazione che la nostra società nutre per gli over 65: pesi inutili, risorse improduttive da cui il nuovo virus in qualche misura ci alleggerisce dando una mano alla selezione naturale.
“Hanno detto ‘però era vecchio’, come se la sua età dovesse attenuare il dolore che provo, come se la sua scomparsa fosse meno importante. Non era un numero, era mio padre”.
Così la figlia di Adriano Trevisan, la prima vittima italiana del virus, ha dichiarato rivolgendosi a tutti coloro che in TV e sui social hanno liquidato la morte del padre 78enne come una statistica, l’inevitabile effetto collaterale di una guerra dove i più deboli sono destinati a soccombere.
Questi vecchi senza volto, senza identità, numeri sui bollettini, non sono però molto diversi dai nostri nonni e genitori anziani, ed è responsabilità di quella maggior parte di cittadini che si fa beffe del contagio perché alla peggio se la caverà con un’influenza contribuire a proteggerli, rispettando le misure di contenimento e le precauzioni suggerite.
La risposta al panico non sta nel razionalizzare l’emergenza comparando il numero dei morti di questa o quell’altra epidemia, né nel minimizzarla solo perché non ci tocca da vicino, ma nel provare ad adottare uno sguardo più umano e collettivo che trascenda per una volta gli interessi personali e sappia vedere dietro i numeri.