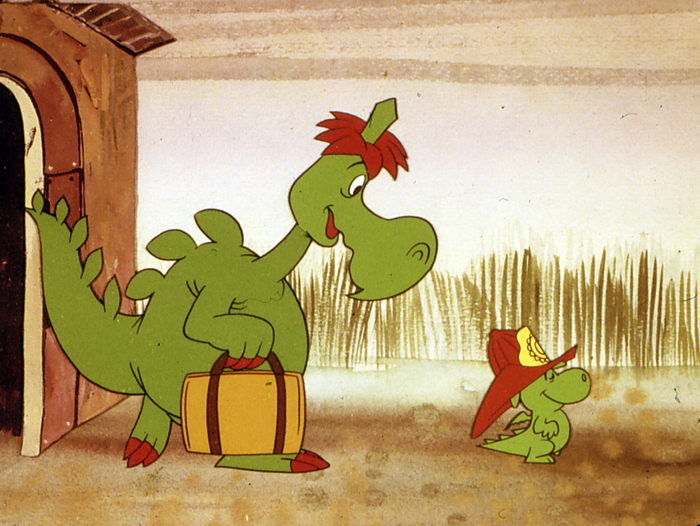“Non sanno studiare, non c’è lavoro e per questo sono ancora più infelici dei loro coetanei”. Ecco come, a parer mio, si dovrebbe raccontare la situazione dei cosiddetti NEET, acronimo di not engaged in education, employment or training, ragazzi e ragazze che non studiano, non lavorano, non si formano.
In un mondo come quello attuale, dove la performance vale più della competenza e la velocità di ricezione delle informazioni più della loro qualità, la generazione di giovani tra i 15 e i 29 anni si trova in una situazione nuova, diversa da quella delle generazioni precedenti e con risposte che si faticano a trovare. Un tempo l’esperienza, la passione e la voglia di mettersi alla prova poteva provenire dagli esempi di adulti interessati e interessanti, o anche dal desiderio di superare e abbattere quegli stessi modelli. Oggi quella funzione di guida (o di “padre da uccidere”) viene a mancare, specialmente nel momento in cui ci si rende conto che i genitori stessi sono fermi a un’ammirazione del “passato che fu” oppure alla spasmodica ricerca di un presente che non gli appartiene più ma che tentano di catturare per non abbandonare l’ideale di giovinezza per sempre.
L’altro elemento da tenere presente è l’arrivo dei social e, con essi, una sempre maggiore possibilità di scelta lavorativa, oltre che di opinioni diverse su argomenti tra i più vari e interconnessi alla quotidianità. I giovani d’oggi si ritrovano bombardati da stimoli ai quali non solo si fa fatica a stare dietro ma che, molto spesso, confondono, destabilizzano fino a rendere impossibile qualsiasi movimento verso il futuro. La mia generazione, rispetto alle precedenti, convive con questa nuova dimensione digitale da sempre e ne riconosce l’estrema utilità; quello a cui nessuno ci ha preparati però è la capacità di selezionare e di discernere ciò che è utile per la nostra individualità da quello che non lo è. E questo è un prezzo che stiamo pagando ora.
In passato, la domanda che più spaventava ma che, allo stesso tempo, dava maggiore spazio a fantasia e voli pindarici era: cosa vuoi fare da grande?
I bambini delle elementari davano risposte che spaziavano dalla ballerina, alla cantante, dalla pop star alla maestra; si viaggiava tra astronavi, camion dei pompieri e volanti di polizia. Oggi questi sogni infantili vengono infranti così presto da presentarsi sempre meno. Viene chiesto, sempre prima, di avere idee chiare e precise che puntino possibilmente a un lavoro ben retribuito, sicuro o che porti al successo (qualsiasi cosa voglio dire). E allora le risposte non sono cambiate solo per le nuove necessità di un mondo che ci sta sempre di più crollando addosso; sono mutate anche adattandosi ai tempi e ai cambiamenti della società.
I lavori tradizionali, per i giovani, hanno perso parte del loro fascino, vista la nascita di nuovi entusiasmanti mestieri legati ai social e alla tecnologia. Per quanto ci sia una componente di fama e ricchezza che intriga i più giovani, che rincorrono modelli e stereotipi molto spesso veicolati dai social stessi, quasi paventando la reale possibilità di poter realizzare tutti i propri sogni, mi pare che la motivazione più potente di questa attrazione sia la possibilità di autonomia e libertà che questi lavori promettono.
Fare l’influencer, consigliare viaggi o ristoranti in diverse parti del mondo, ideare le meccaniche e le grafiche di un videogioco, lavorare con le nuove intelligenze artificiali, creando realtà alternative e utopicamente perfette, soddisfano i bisogni di espressione di sé, di creatività e di originalità che perpetuano uno stato di relazione, viaggio e scoperta, misto a un forte collante di divertimento, che non è assolutamente noto alle generazioni passate. Dove prima il lavoro era un dovere, un obbligo, oggi c’è la reale possibilità e anche la richiesta di rendere la propria passione il mestiere della vita. Un contributo reale alla società tramite la propria individualità e autenticità; il desiderio di rendere il mondo in cui si vive sempre più personale.
Questo dunque il nuovo ideale, il nuovo sogno, che si scontra però con le richieste rigide di una generazione adulta abituata a “lavorare per vivere” e che manda il messaggio che bisogna “vivere per lavorare” e spinge spesso in modo eccessivo verso carriere più stabili, non rispondendo così ai bisogni della nuova generazione. Ecco che, allora, il futuro si ferma di fronte a un bivio: alcuni sono invogliati e supportati a poter continuare a cercare di mettere in pratica il mondo di sogni fatti da bambini, altri non possono fare altro che soccombere al peso di una realtà che viene a sbattere contro la faccia in modo improvviso e che non dà alcuna possibilità di espressione, di essere se stessi. Il compito dell’adulto, a mio modo di vedere, è quello di aiutare, accompagnare e supportare in queste nuove prospettive, rendendosi conto che nella nostra società non si può più parlare in modo categorico di lavori migliori di altri, ma che ciò che importa davvero è trovare il lavoro giusto per sé, la scuola più adatta a sé e le possibilità di esperienza più varie possibili.
Ecco che allora, di fronte all’impossibilità di accettare questo mondo di sogni che cercano di diventare realtà, gli standard diventano non solo più elevati ma quasi impossibili da raggiungere. Secondo le ultime analisi statistiche, il disturbo d’ansia generalizzato e gli attacchi di panico hanno una soglia di comparsa sempre più bassa, passando dalla prima adolescenza all’infanzia (6-7 anni). Persino l’età di comparsa di comportamenti d’abuso di alcol e droghe è scesa fino ai 12 anni. Lavorando in una scuola media, osservo tutti i giorni con rabbia come delle giovani e brillanti menti soffrano sempre prima, con sempre maggiore enfasi, di attacchi di panico nati da un voto leggermente più basso, quasi fosse un insuccesso irreparabile, da una professoressa più severa o, banalmente, da quello che a loro sembra un confronto impietoso rispetto ai coetanei. Questo perché, seppure vi siano sempre maggiori possibilità per quanto riguarda lo sviluppo di una propria idea e personalità, veniamo cresciuti con la cultura del sacrificio che colpevolizza i giovani rappresentandoli come “sfaticati e svogliati” e non come costretti nella chiusura mentale di altri.
In questi anni, non a caso, si è sviluppato il fenomeno del quiet quitting, ossia del fare solo il minimo indispensabile fino alla totale rinuncia ai propri compiti e alla sempre minore attenzione verso la propria salute mentale. Perché indagare il proprio benessere quando è evidente, almeno così a loro pare, che non sono degni del benché minimo supporto? Perché cercare di migliorare la propria vita se veniamo cresciuti con la cultura del più forte dove, non potendoti fidare di nessuno, non puoi fare altro che chiuderti nella tua solitudine? Sarebbe ancora più corretto parlare di loneliness, come la definisce Siracusano, psichiatra romano specializzato nei disturbi dell’umore e dell’affettività, per la quale vi è una completa e irreparabile discrepanza tra ciò che si vorrebbe fare e quello che si vive, in uno stato di mancanza di prospettive e chiusura in sé stessi poiché si è incapaci di dare significato alle cose, siano esse positive o negative.
Alla luce di queste riflessioni, sento la necessità di andare contro l’idea che i miei coetanei non studino e non lavorino per carenza di interessi o mancato coinvolgimento, ritenendo più corretto dire che non ci sono piani di azione concreti, supporti reali che permettano, realisticamente, di combattere contro questa infelicità e assenza di motivazione sempre più dilagante. Già Janet, uno tra i padri fondatori della psicoanalisi, aveva capito che “la noia è una condizione che esprime l’impulso di ricerca interminabile di distrazione; una ricerca che possa salvare dalla depressione e dallo stato di vuoto” (Janet, 1926).
Questo non è un mondo carico di noia, ma, anzi, è una realtà nuova e densa che ci permette di osservare, con meraviglia, una continua evoluzione con modi infiniti di valorizzare le proprie aspirazioni al fine di raggiungere uno stato di felicità, consci e disposti a lottare per i propri sogni. La voglia di cambiamento e di coinvolgimento che viviamo, però, non mi impedisce di credere che non ci si debba arrendere alle eccessive responsabilità e carichi di lavoro per continuare a domandarsi “Cosa vuoi fare da grande?”, anche se grandi lo stiamo già diventando.