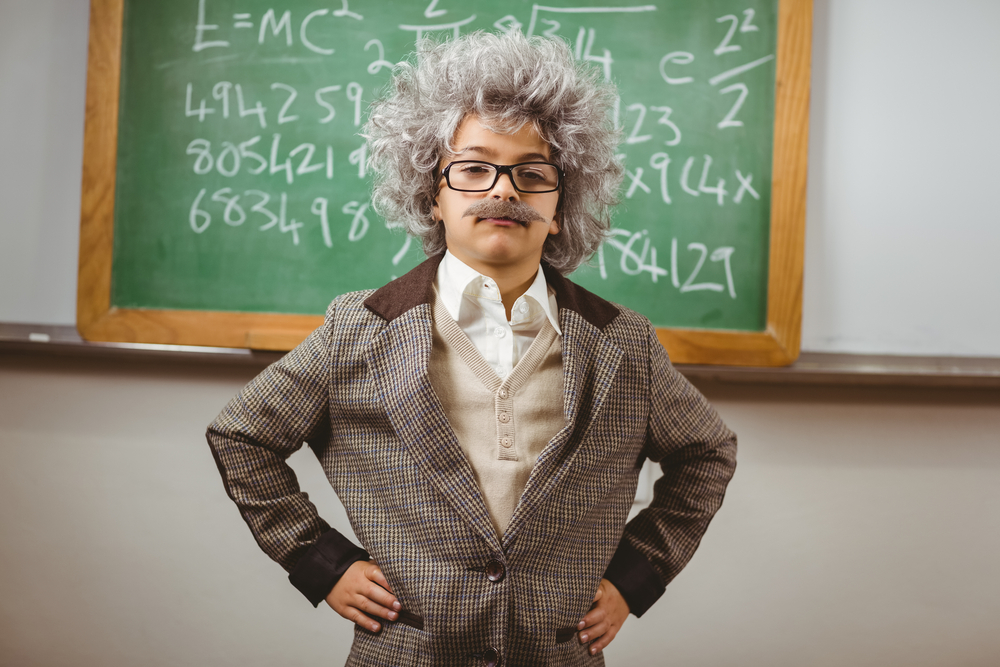Anche se si tratta di un piccolo intervento, magari in day hospital, la paura del chirurgo e della sala operatoria è difficile da eliminare. Le fiction televisive che ci propinano i particolari più cruenti delle operazioni di urgenza non aiutano certo a sdrammatizzare. Invece lo stato d’animo del paziente che affronta il bisturi è in molti casi rilevante per il buon esito dell’intervento, al punto che molti ospedali si servono della collaborazione di uno psicologo per gestire al meglio le ore della vigilia. Senza la pretesa di sostituirmi allo specialista, io posso offrire una mia rassicurante testimonianza di paziente casualmente finito sotto i ferri dopo un controllo cardiaco di routine. A evitare sospetti di interessi pubblicitari ho omesso il nome dell’Ospedale e del noto chirurgo, che nel racconto definirò “il luminare”.
«Lei ha mai fatto un controllo delle carotidi?»
Il tono del cardiologo che mi sta auscultando il collo non mi pare rassicurante.
«Avrei dovuto?», chiedo, già un po’ intimorito.
«A una certa età è un esame assolutamente consigliabile…»
«Qual è una certa età?», provoco.
«Diciamo dopo i cinquanta. Lei è in ritardo di un ventina d’anni. E questo soffio che sento adesso qui a destra è un sintomo che va monitorato. È possibile che sia il segno di una stenosi dell’arteria».
«E in questo caso?», domando sempre più allarmato.
«Dipende. Se la sua carotide è ostruita oltre il settanta per cento è meglio operare».
«Altrimenti?», mormoro in cerca di un’ancora di salvezza.
«Altrimenti il rischio di un ictus cerebrale o di altre complicanze gravi aumenta considerevolmente», sentenzia.
«Ed è un’operazione pericolosa?»
«Diciamo che è un intervento delicato, non particolarmente rischioso, ma va eseguito da un esperto, da un chirurgo di esperienza».
Una settimana dopo sono all’Ospedale. Il primario della chirurgia vascolare, un luminare, mi è stato indicato da un comune amico, a sua volta primario medico e tennista come me. «È uomo di poche parole, ma ha mani e tecnica di prim’ordine», ha garantito. Di carotidi ne ha ripulite alcune migliaia e quanto alla sua bravura, non bastassero gli attestati internazionali, parlano, con la voce del popolo dei pazienti, gli ex-voto che ho davanti agli occhi nel corridoio di accesso al suo studio, tutti inneggianti al mago, all’eroe, al santo che ha salvato la vita di un padre, di una moglie, di un fratello.
Il luminare adesso scruta a lungo l’ecodoppler che mostra a colori i segreti del mio collo, poi scruta a lungo la scheda medica che gli ho fornito, poi scruta me: «Lei dimostra almeno 15 anni meno della sua età anagrafica», esordisce.
«Vuol dire che potrei campare ancora a lungo?», insinuo.
«Vuol dire che la opererò, proprio per consentirle di continuare a sentirsi giovane». Controlla un taccuino, poi chiede: «Domenica lei ha da fare?»
«Vorrei giocare a tennis, e poi vedere la partita dell’Inter…»
«Bene bene. Venga qui dopo le sue partite. Fa un po’ di esami e se non ci sono problemi martedì mattina ci vediamo in sala operatoria».
Per fortuna sono seduto. Mi viene una battuta idiota: «Sarà un piacere rivederla, ma non sarò già addormentato dall’anestesia?»
«No no, lei sarà sveglio. La opero da sveglio. Lei dovrà collaborare. Ma non deve preoccuparsi. Parleremo della sua Inter, se vuole». Per fortuna sono ancora seduto.
In ospedale, alla vigilia dell’intervento, la cardiologa mi spiega meglio: il suo disegnino è addirittura divertente. Le mie carotidi sembrano due tronchi d’albero e portano la linfa a una sola chioma, che sarebbe il mio cervello. Si blocca il flusso della linfa sul tronco intasato, si apre e si ripulisce accuratamente. Ci si deve assicurare che intanto la linfa fluisca attraverso l’altro tronco, ossia che il cervello continui a funzionare. Alla fine si ricuce tutto e l’albero respira meglio di prima. Sulla carta è un bel filmino. Sul mio collo, vedremo.
Martedì all’alba mi spostano dal letto alla lettiga e mi trasferiscono coperto solo da un velo azzurro nella sala preoperatoria. Si muore dal freddo.
«Vede come tremo?», dico all’inferrniera. «Mi dia una coperta».
«Trema per la fifa», risponde sorridendo.
«Ma no», protesto, «ho la fifa per il freddo. Se prendo un accidente adesso, se mi viene un colpo di tosse o uno starnuto durante l’operazione a collo aperto magari succede un disastro, magari ci lascio la pelle…»
Continua a sorridere come si fa coi matti. «Vedrà che tra pochi minuti starà molto meglio», assicura.
In effetti la sala operatoria mi sembra un posto rassicurante, dove tutti sanno esattamente come fare, cosa fare, quando fare.
Mi vien da pensare che in Italia sia l’unico posto così. Mi fanno girare la testa da una parte, presumo che sia la parte opposta a quella del bisturi. Perciò non vedo niente, né sangue, né strumenti. Né capisco quanti siano i medici e gli infermieri. Sento solo una punta di dolore per l’iniezione di anestetico. E poi una specie di solletico al collo, penso che sia il momento in cui tagliano. Una dottoressa chiede come mi chiamo poi continua a comandarmi di aprire e chiudere la mano, e di stare più fermo possibile. A un certo punto un’altra voce femminile dice: «È un bel collo».
«Era bello fino a questa mattina», replico, e lei mostra di apprezzare l’umorismo: «Non mi faccia ridere che la sto operando».
Dell’Inter non si parla ma è meglio perché domenica ha perso.
Tra convenevoli, anestesia, intervento, domande più o meno stupide, risposte più o meno ovvie, ricucitura e controllo postoperatorio se n’è andata la mattinata. Torno in stanza dopo 4 ore e 10 (mia moglie ha contato i minuti), bendato come un fante del 15-18 ma in cuor mio già pronto per tornare a casa, e comunque intenzionato a battere il record di minor degenza postoperatoria.
Cerco complicità tra le infermiere e le trovo tutte ben disposte. Ma certo è lui, il luminare, che devo convincere. Capisco di averlo come alleato solo l’indomani mattina, durante la visita di giro, quando mi presenta al suo codazzo di apprendisti maghi come «il meglio del reparto».
«Allora domani mi fa uscire?», butto lì mentre mia moglie gli fa segno di no.
«Vedremo com’è la ferita», è la sua mezza promessa.
Giovedì alle 10, meno di 48 ore dalla fine dell’intervento, lascio l’ospedale. Io la ferita non l’ho vista ma dev’essere “bella” se i medici hanno dato l’ok. Sì, penso che sia un record.
Adesso che sono passati tre mesi è una riga sottile lunga più di dieci centimetri, che parte da sotto l’orecchio e arriva al pomo d’Adamo. Solo un occhio molto attento può capire di cosa si tratta. A me piace equipararla a una ruga di espressione, di quelle che solcano il viso quando uno vive molto a lungo.